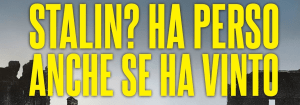Sono seduto al tavolino di una birreria, all’aperto, con degli amici.
Ad un certo punto sento il cellulare squillare. Guardo lo schermo, rispondo euforico, abitudine ormai consolidata nella mia piccola cerchia di amici, berciando il suo soprannome. Roberto (è uno pseudonimo, per motivi di privacy) è un ragazzo italianissimo, padre siciliano e madre filippina. Scherzando sulla sua carnagione scura, ormai da anni è per noi “il negro”.
Nemmeno il tempo di finire la parola, mi rendo conto che, al tavolo di fronte, sta seduto un ragazzino di origini africane, probabilmente ha un appuntamento galante con la ragazza che le sta seduta di fianco. Inorridisco immediatamente per via della magra figura e farfuglio al telefono, mentre lui fa un cenno verso di me, evidentemente molto risentito per la mia infelice scelta dei termini, sentendosi personalmente chiamato in causa in maniera beffarda. Cosa, ovviamente, assolutamente al di fuori delle mie intenzioni. Mi alzo dal tavolo, gli occhi bassi colmi di vergogna, vado verso di lui e farfuglio le mie scuse, giustificando la mia esclamazione e chiedendogli se posso offrirgli da bere per rimediare, più ai miei sensi di colpa, poiché l’offesa non è stata intenzionale. Rifiuta, mentre nei suoi occhi intravedo una ferita, un passato che riemerge, la tristezza dell’umiliazione subita di fronte alla propria donna. Mi sento crollare. Porgo a tutti i presenti con me le mie pubbliche scuse e, temendo di poter solamente peggiorare le cose, torno a sedere. Nel giro di tre minuti i due ragazzi si erano alzati ed erano andati via.
Parte il dibattito. Patrick, un ragazzo rumeno seduto con noi (ovviamente anche questo è uno pseudonimo) condanna il mio gesto, sostenendo che è troppo facile nascondersi dietro l’involontarietà delle proprie azioni per giustificarle: gli omicidi involontari avvengono, e delle persone muoiono per un errore. Alina e Melania sostengono invece che vi sono delle differenze fatte dalle intenzioni di chi proferisce il verbo e dal contesto in cui inserisce i termini. Io esordisco, finalmente, farfugliando (e tutti si trovano d’accordo) sostenendo che la differenza non la fa la parola, in quanto è solo un’espressione comunicativa per indicare qualcosa o qualcuno, ma la fa l’orecchio di chi ascolta. Se non v’era malizia nelle mie parole e qualcuno si è sentito chiamato in causa, significa ch’egli per primo coglie un accezione negativa in un termine che, di per sé, non è né buono né cattivo, né giusto né sbagliato, ma solamente un mezzo per riconoscere un concetto.
Poi penso all’immagine che evoca nella mia mente la parola “negro”. Penso a un popolo ridotto in schiavitù più di 500 anni fa, trasportato in condizioni disumane che ben s’accostano a quelle dell’inferno dantesco, sfruttate senza sosta e senza un briciolo di dignità, come animali, nei campi di cacao e di barbabietole e di canne da zucchero. Penso alla colonizzazione Europea in Africa, penso alle donne stuprate in Abissinia durante la “crociata” fascista, penso ad una guerra civile americana, penso a Matin Luther King, a John Brown, a Malcolm X, a Thomas Sankara…
Definirli “di colore”, cercando di attenuarne il significato e la storia, forse, sarebbe stato offensivo.