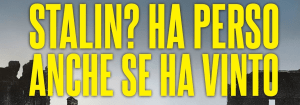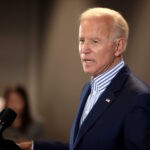L’abuso del termine “inclusione”
Oggi la parola “inclusione” è sulla bocca di tutti.
Si parla di inclusione a scuola, tanto per gli studenti con disabilità, quanto per gli studenti di etnia diversa da quella italiana.
Si usa il termine inclusione per i soggetti con patologie psichiatriche, per gli anziani, per i fragili, per i trans… Insomma, gettiamo tutti coloro che consideriamo “diversi”, in base a una personalissima prospettiva, dentro un unico calderone e rimescoliamo con cura, in attesa che le istituzioni prendano sul serio la questione con concreti piani di aiuto a persone non diverse, ma che quotidianamente devono fare i conti con strutture non sufficientemente attrezzate, personale inesistente e, laddove opera, non lo può fare al meglio delle sue possibilità; famiglie abbandonate a sé stesse, incapaci di gestire situazioni più grandi di loro, e mi fermo qui, l’elenco andrebbe quasi all’infinito.
Ritornando al termine, abusato, di “inclusione”, parrebbe, quindi, che dei molteplici e importanti ruoli di cui è investita la società, che è bene ricordare è formata da ognuno di noi, sia quello di essere inclusiva.
La società e davvero inclusiva?
Intanto, mi domando: “lo è davvero?”. E poi, è rispettoso usare tale accezione nei confronti di una persona, sia un diversamente abile o un individuo che ha deciso di cambiare sesso?
Se si parte dal presupposto dell’inclusione del diverso, la partenza è già un fallimento.
“Diverso”: una parola, uno stigma
“Diverso”, perché?
Perché invece di camminare sulle proprie gambe utilizza, come ausilio, la sedia a rotelle o una protesi? Oppure perché ha compreso che in quel genere sessuale non si riconosce e, con il sacrosanto diritto di persona libera, ha deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico?
La società, a mio avviso, non è inclusiva, usa solo degli stigmi. Stigmatizza il diverso da sé non tenendo conto che l’altro è una persona, con il dramma di non sentirsi accettato esattamente così com’è.
Ognuno di noi è un diverso, eppure guardiamo sempre nella sacca dei difetti altrui, un modo più semplice per prendere le distanze dalla paura di quello che non comprendiamo.
L’inclusività come maschera
In fondo, mascherare costa meno fatica dell’affrontare, ma solo in apparenza, poiché non si elimina lo sporco mettendolo sotto il tappeto: lo si fa solo crescere, esattamente come le ombre che svolazzano nei nostri pensieri.
Quando si accetta una persona nella sua totalità, che bisogno c’è di parlarne usando la parola “inclusione”?
Accettazione: partiamo dalla famiglia
Credo, invece, sia meglio lavorare sull’accettazione, un lavoro che deve iniziare in famiglia.
Ancora, oggi, in ambito familiare, e la cronaca è, ahimè, testimone, i litigi si trasformano in vere e proprie tragedie quando, ad esempio, un genitore scopre di avere un figlio omosessuale o transessuale.
Vergogna, frustrazione, impotenza… emozioni e stati d’animo convulsi che prendono il sopravvento sul buon senso e l’amore genitoriale.
Cenni letterari
Concludo queste mie riflessioni con una poesia di Giovanna Cristina Vivinetto, giovane autrice siracusana.
La lirica è tratta dal libro “Dolore minimo”, opera prima della scrittrice, pubblicata nel 2018 per Interlinea.
La Vivinetto, con il suo libro, è la prima ad affrontare in versi le scottanti e delicate tematiche della disforia di genere e della transessualità.
“Quando nacqui mia madre
mi fece un dono antichissimo,
il dono dell’indovino Tiresia:
mutare sesso una volta nella vita.
Già dal primo vagito comprese
che il mio crescere sarebbe stato
un ribelle scrollarsi dalla carne,
una lotta fratricida tra spirito
e pelle. Un annichilimento.
Così mi diede i suoi vestiti,
le sue scarpe, i suoi rossetti;
mi disse: «prendi figlio mio,
diventa ciò che sei
se ciò che sei non sei potuto essere».
Divenni indovina, un’altra Tiresia.
Praticai l’arte della veggenza,
mi feci maga, strega, donna
e mi arresi al bisbiglio del corpo
-cedetti alla sua femminea seduzione.
Fu allora che mia madre
si perpetuò in me, mi rese
figlia cadetta del mio tempo,
in cui si può vivere bene a patto
che si vaghi in tondo, ciechi
-che si celi, proprio come Tiresia,
un mistero che non si può dire.”
Perché Tiresia?
Secondo la mitologia greca, Tiresia, mentre passeggia sul monte Cillene per alcuni, Citerone per altri, si imbatte in due serpenti nell’atto dell’accoppiamento; disgustato dalla scena, pensa bene di sopprimere la femmina.
In quello stesso istante, Tiresia viene trasformato da uomo in donna.
Nelle vesti femminee Tiresia vive per ben sette anni, assaporando tutti i piaceri concessi a una donna.
Trascorso questo periodo, si trova nuovamente dinanzi alla stessa scena di due serpenti; stavolta ammazza il maschio e, in quel medesimo momento, ritorna uomo.